
I PIÙ LETTI DEL MESE
-
BastaBugie consiglia

LA SCUOLA IN LOMBARDIA
Incontro con le scuole parentali cattoliche
Osservatorio Van Thuan
e Don Stefano Bimbi
Vanzaghello, 30/11/2024
-
Il 1° libro di BastaBugie

CI HANNO PRESO PER IL COVID
Per non dimenticare tre anni di abusi di potere
Anno 2023 pag. 514 € 16
-

Audio registrati
-
La censura di YouTube

YouTube ha censurato in passato circa il 20% dei video che abbiamo pubblicato e oggi ci impedisce di pubblicare video con temi contrari al politicamente corretto (islam, gay, covid, ecc.)

SCEGLI UN ARGOMENTO
 Aborto
Aborto America
America Animalisti e vegetariani
Animalisti e vegetariani Attualità
Attualità Cinema
Cinema Comunismo
Comunismo Cristianesimo
Cristianesimo Ecologia
Ecologia Economia
Economia Eutanasia
Eutanasia Evoluzionismo
Evoluzionismo Famiglia e matrimonio
Famiglia e matrimonio Fecondazione artificiale
Fecondazione artificiale Immigrazione
Immigrazione Islam
Islam Libri
Libri Liturgia e sacramenti
Liturgia e sacramenti Morale
Morale Omelie
Omelie Omosessualità
Omosessualità Pedofilia
Pedofilia Pillole
Pillole Politica
Politica Santi e beati
Santi e beati Scienza
Scienza Scuola
Scuola Storia
Storia Televisione
Televisione
« Torna agli articoli di I
 IL SUICIDIO DI LIZZANI VIENE USATO DAI MEDIA PER CHIEDERE L'EUTANASIA
IL SUICIDIO DI LIZZANI VIENE USATO DAI MEDIA PER CHIEDERE L'EUTANASIA
Carlo Lizzani, il 5 ottobre scorso si è tolto la vita. Aveva 91 anni ed era depresso perché non più autosufficiente. Ultimo di altri recenti suicidi “eccellenti”, come quello del collega Mario Monicelli, dello scrittore Franco Lucentini, del giornalista Lucio Magri e del giudice Pietro D’Amico. “Stacco la chiave” ha lasciato scritto su un biglietto poco prima di gettarsi dal terzo piano di casa sua. La stampa, occupandosi della vicenda, ha fornito come nel passato la summa laicale del concetto di eutanasia sfornando i soliti luoghi comuni. Spigolando qua e là tentiamo di dare risposta alle obiezioni più ricorrenti.
Il regista Franz Ozpetek su Repubblica afferma: «Gettarsi nel vuoto è un gesto davvero estremo, quello sì che richiede un enorme coraggio». Astraendo dal caso concreto, noi siamo rimasti che chi si toglie la vita è un vigliacco, uno che scappa di fronte al dolore ed è incapace di colmare il vuoto interiore. Qui le virtù a dar retta ad Ozpetek sono capovolte: la fortezza, da virtù che domina le passioni, è diventata serva di esse.
Passiamo oltre. Alcuni, tra cui la figlia di Lizzani a cui insieme al fratello Francesco va il nostro rispettoso cordoglio, dicono che non capiscono il gesto del regista ma che rispettano la sua scelta. La Chiesa cattolica su questo argomento, come su molti altri simili, fa sempre un distinguo tra l’errore, che è sempre da condannare: mai è lecito togliersi la vita. E l’errante, da accogliere sempre con misericordia: non sta a noi giudicare il grado di responsabilità morale di chi ha compiuto una simile scelta. Lizzani compreso.
Terza spigolatura. Vittorio Feltri su Il Giornale scrive: «Negare la libertà di vivere e di morire nei modi che preferisce un individuo, significa negargli il libero arbitrio, che pure è contemplato nei testi cosiddetti sacri. E qui c'è una contraddizione evidente». Feltri ripete la solita vulgata su concetti chiave come “libero arbitrio” e “libertà”. In sintesi: il libero arbitrio è la possibilità di scegliere tra il bene e il male. Se scelgo il bene (la vita) allora scatta la libertà come conseguenza naturale, se scelgo il male (suicidio), allora sono schiavo del male. La libertà non è fare quello che si vuole, ma quello che vuole il mio bene. La libertà è sempre connessa con il bene. Tizio che vuole essere libero di drogarsi non è realmente libero, bensì schiavo della droga. Chi decide di togliere il disturbo perché depresso non è libero, ma è sotto tortura del dolore, del male di vivere.
Ma il meglio su questa brutta faccenda di cronaca viene dall’alfiere del “diritto a morire”, l’oncologo Umberto Veronesi che intervistato su La Stampa precisa che la morte di Lizzani è «una forte forma di denuncia e di protesta». La solita mania di alcuni sostenitori del pensiero levantino di buttare tutto in politica quando invece il gesto di Lizzani è assolutamente privato, sebbene sostenesse le battaglie radicali per la legalizzazione dell’eutanasia e sebbene tale gesto debba ovviamente interrogare le coscienze di tutti. Una strana schizofrenia prende i laici: dicono che non si può giudicare Lizzani perché la morte è affare privatissimo e subito dopo ne fanno un affare di Stato, tanto che le radicali Filomena Gallo e Mina Welby hanno usato da sponda questa tragica morte per rilanciare un delibera sul fine vita già presentata presso il Comune di Roma.
Sempre Veronesi: «in Italia, e anche in molte parti d’Europa, il diritto di morire con dignità è una conquista ancora da fare. Non è possibile immaginare Mario Monicelli che si alza dal letto di un ospedale, che apre la finestra e si butta giù o i tanti che lo fanno senza avere titoli di giornale». E poi giù ad elencare come questi poveri aspiranti suicidi si devono ingegnare per togliere il disturbo, roba da terzo mondo. Gli fanno eco Feltri – «se uno è stanco di stare su questa terra, non lo si deve costringere a gettarsi dalla finestra o a spararsi, ma sarebbe opportuno che le strutture sanitarie lo aiutassero, in forma civile e non cruenta, a troncare le proprie tribolazioni» - il figlio di Lizzani sul Messaggero – «Papà avrebbe certo preferito un’altra via per morire, quella che un paese civile gli avrebbe consentito» – il dottor Silvio Viale sempre sullo stesso quotidiano – «in un paese civile non si dovrebbe consentire di essere costretti a morire così» - e il già citato Ozpetek su Twitter: «l’unica eutanasia che l’Italia concede agli anziani. Gettarsi nel vuoto». Insomma se l’eutanasia fosse legale non assisteremmo più a questo scempio. In fin dei conti a spingerlo giù nel vuoto sono state le nostre leggi che, paradosso dei paradossi, tutelano la vita contro la tentazione di farla finita.
Come rispondere? In primo luogo non nascondiamoci dietro un dito: se il problema fosse davvero quello di morire in un letto di ospedale in modo incruento non basterebbe recarsi nella vicina Svizzera come hanno già fatto in tanti?
E poi è la stessa manfrina che abbiamo sentito migliaia di volte a proposito dell’aborto: si deve dare la possibilità di uccidere il proprio figlio in sicurezza. Pare che l’unica cosa a cui si debba prestare attenzione non sia tanto quella di evitare omicidi e suicidi, ma che questi avvengano in modo pulito, formale, in bianchi letti di ospedale con la firma a piè di pagina del testamento biologico di un medico. È questione di stile: buttarsi giù da una finestra è volgare – «il corpo di una persona schiacciata sul marciapiedi mi sembra un torto alla dignità» aggiunge Ozpetek - passar a miglior vita con una iniezione del medico è più civile. Ciò che disgusta non è il suicidio in quanto tale ma è solo il modo di togliersi la vita.
Un appunto sulla questione della dignità umana tanto tirata in ballo in storie come queste. La nostra natura umana chiede ed esige la vita. Non concedere e non concedersi questo bene è svilire l’intima preziosità della persona umana, cioè la sua dignità: non trattare l’uomo da uomo. È il suicidio che non è atto degno dell’uomo, non il continuare a vivere nonostante si soffra nel corpo e nello spirito. E non ci sono né dolori né malattie che possano da sé intaccare la dignità di una persona. Un diamante nel fango è sempre un diamante.
Comunque dietro alle parole di Veronesi si cela il solito giochetto: i sucidi sono un problema sociale. Come superarlo? Legalizziamo l’eutanasia. Geniale. È come dire: i furti e gli omicidi sono un problema sociale. Come risolvere questo problema? Legalizziamoli. Vietare è da barbari – “un proibizionismo insensato” chiosa il figlio di Lizzani - e i poveracci si devono arrangiare come possono per delinquere.
Poi l’intervistatore pungola Veronesi sul fatto che molti si tolgono la vita perché depressi. Veronesi così risponde: «È un problema vero ma non parlerei di depressione, piuttosto di demotivazione alla vita. Sono persone che pensano: sono anziano, non sto bene, sono di peso alla società e alla famiglia, perché devo vivere?» Al di là del fatto che la domanda retorica di Veronesi speriamo che non sia intesa da nessuno come mellifluo e funereo suggerimento per gesti estremi, ci pare che la demotivazione alla vita sia un modo elegante per dire depresso e quindi si giochi un po’ con le parole. Ma comunque ci chiediamo: non è meglio curare la demotivazione esistenziale piuttosto che incentivare il suicidio? La prima opzione è una soluzione al problema, l’altra non elimina il problema ma solo chi se lo pone. L’idea di Veronesi è di eliminare il dolore di vivere insieme a chi prova questo dolore. “Dai papà prendiamoci ancora un caffè e parliamone insieme”, questa è la frase che si rammarica di non aver detto al padre il figlio Francesco allorché aveva intuito che pensieri di morte ormai avevano preso fissa dimore nel suo animo. Forse sarebbe bastato così poco per evitare la tragedia.
Veronesi viene sollecitato ancor di più dall’intervistatore quando questi gli ricorda che, per chi crede, la vita è un dono. Il medico meneghino risponde: «Chi è fedele agli insegnamenti della Chiesa li segua ma non può pretendere di invadere la legge civile. Chi non è credente ha il diritto di non ascoltare i dettami della religione». Stessa musica è cantata da Vittorio Feltri su Il Giornale: «Ciò che invece è incomprensibile è la loro [dei credenti] pretesa di imporre a tutti, anche agli atei e agli agnostici, i principi ai quali si ispirano, tra cui l'idea che nessuno possa scegliere di tirare le cuoia volontariamente quando e come vuole e per i motivi che ritiene validi». Intanto ad oggi l’eutanasia è considerata dal nostro ordinamento giuridico un reato: quindi non c’è invasione di campo alcuno da parte del credente perché l’aiuto al suicidio e l’omicidio del consenziente sono materie penali laicissime. E poi non serve essere credenti per dire no all’eutanasia – basta usare la ragione, strumento che è in possesso anche ai non credenti - a meno che Veronesi e Feltri non credano che su vita e morte il copyright sia in mano ai soli cattolici. Dire che la vita, la proprietà, la conoscenza, la salute sono dei beni e quindi sono cose da tutelare non è imporre una propria personalissima visione di fede, ma è riconoscere con il lume dell’intelletto naturale una verità che ci precede.
Veronesi poi aggiunge che vivere «senza coscienza, senza ricordi, senza pensieri. È una forzatura, bisognerebbe assecondare la natura». E allora perché quando un paziente malato di tumore si reca da Veronesi per essere curato quest’ultimo non lascia fare alla natura il suo corso e non lo lascia morire senza cure?
Infine l’intervista si chiude con questa domanda: «Che cosa direbbe agli italiani che non hanno più voglia di vivere?». Veronesi non ha dubbi in proposito: «Di procurarsi una corda o di aprire una finestra: non c’è altra soluzione legittima o accettabile. È assurdo perché uccidersi non è reato, anche il tentato suicidio non è punibile. Allora perché è reato aiutare qualcuno se questa persona ha scritto chiaramente qual è la sua volontà?». A parte il fatto che la prima frase del nostro potrebbe configurare apologia di reato se non istigazione al suicidio, c’è da riflettere non poco sulle altre due affermazioni di Veronesi, davvero pronunciate con disinvoltura. Innanzitutto tentiamo di spiegare al luminare che nel nostro ordinamento giuridico il suicidio non è considerato reato perché sarebbe un po’ macabro e grottesco mettere dietro le sbarre un cadavere. Il tentato suicidio invece non è punibile, non perché lo Stato lo approvi – non tutto ciò che non è punito è da considerarsi legittimo si spiega al primo anno di giurisprudenza alle matricole – bensì perché sarebbe inutile spedire in carcere o comminare una multa al tentato suicida. I suoi problemi non si risolvono con la reclusione e questa sanzione potrebbe solo aggravarli. Se fosse legittimo come dice Veronesi tentare di togliersi la vita non si capisce il motivo per cui il nostro Stato punisce chi aiuta a suicidarsi (580 cp) o chi uccide un terzo con il suo consenso (579 cp). Se il suicidio fosse cosa buona l’omicida del consenziente potrebbe solo ricevere un encomio. Lo sfavore del nostro ordinamento invece verso il suicidio lo si deduce proprio da queste due norme che puniscono chi aiuta un altro a togliersi la vita. Pare che oltre a Lizzani anche la logica sia morta. Ma non per suicidio.
-
Pubblicato 10 anni fa...

LE TASSE SULLA CASA
Furti legalizzati
di Rino Cammilleri
Articolo del 28 novembre 2014
-
Libro della settimana

SI E' FATTO CARNE
La storicità dei Vangeli
di Luisella Scrosati
Anno 2024 / pag. 144 / € 10
-
Video della settimana

CAMBIAMENTO CLIMATICO
Contraddizioni della COP29
di Silver Nervuti (6 minuti)
-
Da FilmGarantiti.it

NEL 2000 NON SORGE IL SOLE
Il romanzo 1984 di George Orwell
Giudizio: consigliato (*)
Genere: drammatico (1956)
Guarda gratis su YouTube
-
I dossier di BastaBugie
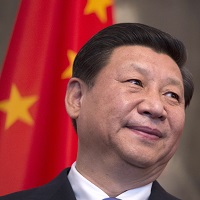
CINA-VATICANO
L'accordo disastroso
Dossier: 8 articoli e 1 video
-
Santo della settimana

LA PICCOLA LI
Martire cinese per l'eucaristia
di Suor Emmanuel Maillard
-
Video per la formazione

IL DIGIUNO
Norme pratiche
di P. Serafino Tognetti
Durata: 17' (09/11/2024)
-
Personaggi del passato

RODNEY STARK
Sociologo
Una mente libera
1934 - 2022 (88 anni)







