
I PIÙ LETTI DEL MESE
-
Il 1° libro di BastaBugie

CI HANNO PRESO PER IL COVID
Per non dimenticare tre anni di abusi di potere
Anno 2023 pag. 514 € 16
-

Audio registrati
-
La censura di YouTube

YouTube ha censurato in passato circa il 20% dei video che abbiamo pubblicato e oggi ci impedisce di pubblicare video con temi contrari al politicamente corretto (islam, gay, covid, ecc.)

SCEGLI UN ARGOMENTO
 Aborto
Aborto America
America Animalisti e vegetariani
Animalisti e vegetariani Attualità
Attualità Cinema
Cinema Comunismo
Comunismo Cristianesimo
Cristianesimo Ecologia
Ecologia Economia
Economia Eutanasia
Eutanasia Evoluzionismo
Evoluzionismo Famiglia e matrimonio
Famiglia e matrimonio Fecondazione artificiale
Fecondazione artificiale Immigrazione
Immigrazione Islam
Islam Libri
Libri Liturgia e sacramenti
Liturgia e sacramenti Morale
Morale Omelie
Omelie Omosessualità
Omosessualità Pedofilia
Pedofilia Pillole
Pillole Politica
Politica Santi e beati
Santi e beati Scienza
Scienza Scuola
Scuola Storia
Storia Televisione
Televisione
« Torna alla edizione
 IL SUMMIT SUL CLIMA DI BIDEN E' UN ''SUCCESSO''... MA SOLO PER LA CINA
IL SUMMIT SUL CLIMA DI BIDEN E' UN ''SUCCESSO''... MA SOLO PER LA CINA
Il summit sul clima di Joe Biden è stato un «successo». Lo scrivono tutti i giornali, parlando del vertice in videoconferenza dove i principali leader mondiali hanno fatto nuove promesse sul taglio dei gas serra. Ma c'è un paese che ha beneficiato più di tutti dell'appuntamento green, ed è la Cina. Mentre gli altri Stati, incitati dai discorsi di Greta Thunberg e papa Francesco, facevano a gara a migliorare gli impegni assunti con l'accordo di Parigi, Xi Jinping si è guadagnato il plauso dei media di tutto il mondo, pur senza prendere nessun impegno.
Il «green» è la vera gallinella dalle uova d'oro per Pechino. Criticato a livello internazionale su tutti i fronti possibili, ha capito che è sufficiente fare roboanti discorsi sul clima per ottenere una tregua. Anche se poi, alle parole, non seguono mai i fatti.
Xi ha disperatamente bisogno di migliorare l'immagine della Cina. Ha scatenato una pandemia che ha messo in ginocchio l'economia mondiale. È sotto accusa per il «genocidio» degli uiguri. Ha azzerato le libertà civili di Hong Kong in violazione degli accordi internazionali presi con il Regno Unito. Minaccia costantemente di invadere Taiwan. Protegge la dittatura militare del Myanmar, che sta massacrando il suo stesso popolo, impendendo all'Onu di intervenire. Ruba la tecnologia agli alleati industriali, viola le regole del Wto, invade il mercato con merci a basso costo danneggiando i partner commerciali. Sanziona tutti coloro che osano muovere delle critiche.
IL CLIMA È IL CAVALLO DI TROIA DI XI
Nessun paese al mondo potrebbe resistere a tante malefatte. Non è dunque sorprendente che la Cina abbia accettato l'invito di Biden a partecipare al summit virtuale sul clima. Pechino ha disperatamente bisogno di promuovere agli occhi del mondo un'immagine più responsabile del regime e ha trovato nel clima il cavallo di Troia che cercava. Il vertice americano ne è stata la riprova. Xi Jinping non ha promesso nulla, eppure ha ricevuto l'elogio di tutto il mondo.
Gli Usa si sono impegnati a tagliare le emissioni di anidride carbonica almeno del 52% entro il 2030; l'Ue le ridurrà del 55% entro il 2030 con l'obiettivo di arrivare a zero emissioni nel 2050. Il Giappone ridimensionerà i gas del 46% entro il 2030, il Regno Unito del 78% entro il 2035. E la Cina? Xi ha vagamente parlato di «investimenti sostenibili», «Via della seta verde», «riduzione del tasso di crescita nei consumi di carbone nei prossimi cinque anni» (riduzione della crescita, non dei consumi). Ha poi ribadito l'impegno degli accordi di Parigi: raggiungere il picco delle sue emissioni di Co2 nel 2030 e la neutralità carbonica nel 2060.
Solo tra 10 e 40 anni, dunque, si potrà avere la certezza se Pechino fa sul serio oppure no. Nel frattempo, però, si può dare un'occhiata a come la Cina si sta muovendo per raggiungere i suoi mirabolanti obiettivi. Secondo il gruppo di analisi finanziare TransitionZero, la Cina potrebbe risparmiare fino a 1,6 triliardi di dollari se sostituisse il carbone con alternative più pulite. Eppure «al momento non c'è traccia di questa transizione».
Secondo i dati diffusi dalla Cina, il carbone soddisfa il 56,8% del fabbisogno energetico del paese. Pechino resta il principale emettitore di gas serra nel mondo, a livello assoluto, e a breve supererà gli Stati Uniti nella classifica dei paesi per inquinamento pro capite. Nel 2020, le emissioni in Cina sono aumentate dell'1,7%, raggiugendo i 14.400 milioni di tonnellate, pari alle emissioni di 180 paesi del mondo messi insieme.
OLTRE 200 NUOVE CENTRALI A CARBONE
In Cina, secondo i dati del Global Energy Monitor, sono attive 1.082 centrali a carbone. Per mantenere gli impegni presi, dovrebbe chiuderne nei prossimi dieci anni 588. Invece, 92 nuove centrali sono in costruzione e altre 135 sono in fase di progettazione. Ogni nuova centrale difficilmente verrà spenta «prima di 40 anni» per non generare perdite. Se nel 2020 il mondo ha spento centrali a carbone per un totale di 37,8 gigawatts in meno, la Cina ne ha costruite per un totale di 38,4 gigawatt in più, vanificando quindi gli sforzi del mondo intero. Ancora, se nel 2019 la Cina aveva commissionato il 64% di tutte le nuove centrali a carbone del mondo, nel 2020 il dato è aumentato al 76%. Nel computo, non sono considerate quelle costruite all'estero.
Paradossale, infine, è il fatto che il Dragone domini i settori delle automobili elettriche, dei pannelli solari, delle turbine eoliche e delle batterie. Mentre guadagna dalle promesse green degli altri paesi, quindi, non fa nulla in patria per limitare le emissioni di Co2. Secondo il Climate Action Tracker, l'operato della Cina rispetto agli obiettivi preposti è «altamente insufficiente». È da notare anche che nessun paese fortemente industrializzato guadagna la sufficienza nella classifica. Gli unici paesi definiti “modello” sono al momento Marocco e Gambia.
Xie Chunping, membro del Grantham Research Institute on Climate Change, ha affermato che se la Cina vuole mantenere le sue promesse deve ridurre le sue emissioni del 66% entro il 2030. Come riuscirà a farlo in soli nove anni, quando ancora oggi le sue emissioni aumentano anno dopo anno, è un mistero. Ma ai summit sul clima come quello americano non si parla di dati. Si fanno solo promesse. Xi Jinping questa volta non ha fatto neanche quelle. Eppure ha ricevuto l'applauso del mondo intero. Il «green» si conferma un affare d'oro per la Cina.
Nota di BastaBugie: l'autore del precedente articolo, Leone Grotti, nell'articolo seguente dal titolo "La rivoluzione green si fonda sullo sfruttamento del lavoro forzato in Cina?" rivela che il 95% dei pannelli solari sul mercato è realizzato con materiali lavorati in Cina nel Xinjiang, dove si sfrutta il lavoro forzato degli uiguri.
Ecco l'articolo completo pubblicato su Tempi il 29 aprile 2021:
La battaglia per mitigare il cambiamento climatico e la rivoluzione green sognate dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti di Joe Biden potrebbero basarsi su un'amara verità: lo sfruttamento del lavoro forzato in Cina. Si fanno sempre più forti, infatti, i sospetti sulla produzione dei pannelli solari, settore in cui Pechino è leader in ogni fase del processo, concentrata nella provincia del Xinjiang.
I pannelli funzionano grazie alla capacità delle celle fotovoltaiche di assorbire e convertire la luce del sole in energia. La stragrande maggioranza delle celle sono fatte con componenti di polisilicio. La produzione globale del polisilicio è per l'82% in mano alla Cina, che nel 2010 deteneva soltanto il 26% del mercato. Nello stesso lasso di tempo la fetta di mercato americana è scesa dal 35 al 5%.
Come affermato dall'esperto di Bloomberg New Energy Finance, Jenny Chase, «almeno il 95% dei pannelli solari presenti sul mercato», anche prodotti in altri paesi, «sono fatti di polisilicio che proviene dal Xinjiang». È in questa provincia, infatti, che si trovano quattro dei cinque produttori più grandi al mondo, in grado di offrire prezzi imbattibili: Gcl-Poly, East Hope Group, Daqo New Energy e Xinte Energy.
Alla base della competitività delle aziende cinesi non c'è soltanto il possibile utilizzo di lavoro forzato. Ma anche il minor costo dell'energia. Per produrre il polisilicio è necessario un processo industriale che richiede l'utilizzo di fornaci ad altissime temperature. Il 40% dei costi operativi di queste aziende è assorbito dall'energia. E in Xinjiang l'energia viene prodotta con economiche, ma iper inquinanti, centrali a carbone. Ogni fabbrica è infatti costruita di fianco a una di queste centrali che «mina alla radice i benefici per l'ambiente eventualmente prodotti dai pannelli solari», spiega Bloomberg.
Il Xinjiang è anche la provincia dove nel 2017 è iniziata la più grande incarcerazione di massa di una minoranza etnica della storia. Da allora, sono stati detenuti senza processo in enormi campi di rieducazione attraverso il lavoro 1,8 milioni di uiguri. La loro colpa è di essere musulmani e di conseguenza, secondo Pechino, estremisti e poco patriottici. Il Partito comunista cinese ha sempre negato le incarcerazioni di massa e lo sfruttamento del lavoro degli internati, spiegando che si tratta di programmi di «reinserimento nella società» attraverso periodi di soggiorno in «centri di formazione». Qui, sempre secondo il regime, gli uiguri possono imparare un nuovo lavoro. La verità, confermata da centinaia di testimonianze, è che gli uiguri vengono rinchiusi, abusati, torturati fisicamente e psicologicamente contro la loro volontà. In molti casi, sono anche sottoposti ai lavori forzati.
A gennaio, come riportato dal New York Times, la società di consulenze Horizon Advisory ha realizzato un rapporto sulle aziende che si occupano di tecnologia per lo sfruttamento dell'energia solare in Cina. All'interno si legge ad esempio che Gcl-Poly ha accettato «un surplus di forza lavoro» proveniente da una regione rurale del Xinjiang nel 2020. La stessa cosa era avvenuta nel 2018. Una filiale di Jinko Solar ha ricevuto sussidi per impiegare nel 2020 almeno «40 lavoratori poveri provenienti dal sud del Xinjiang». Una filiale di East Hope «ha accettato 235 impiegati provenienti da una minoranza etnica del Xinjiang meridionale».
Secondo una ricerca condotta dal Center for Strategic and International Studies, il think tank più autorevole degli Stati Uniti e uno dei più importanti del mondo, simili diciture rappresentano un paravento per nascondere il lavoro forzato. Gli uiguri impiegati, infatti, non possono né rifiutare né abbandonare il lavoro, non possono allontanarsi dalla fabbrica né partecipare a funzioni religiose, spesso non vengono pagati o non ricevono un salario adeguato, subiscono sessioni di indottrinamento e minacce di arresto.
Poiché la Cina non permette ai giornalisti di visitare le fabbriche in questione e parlare con gli operai, è impossibile essere certi al 100% che si tratti di lavoro forzato. Ma i segnali vanno in questa direzione. Bloomberg è uno dei pochi media che ha avuto accesso alla regione del Xinjiang per confermare i sospetti e ha pubblicato un lungo reportage ad aprile.
I giornalisti, accompagnati da funzionari governativi con armi automatiche in mano, non hanno potuto entrare nelle aziende incriminate «a causa del Covid-19». Quasi tutte le foto che hanno scattato sono state cancellate dai funzionari, tranne quelle che mostrano la vicinanza delle fabbriche di polisilicio alle inquinantissime centrali a carbone.
Un altro rapporto realizzato da S&P Global Market conferma però i timori e l'importante utilizzo di «lavoro volontario» da parte delle aziende del settore energetico che lavorano nel Xinjiang. E come dichiarato da Rune Steenberg, esperto tedesco che lavora con la diaspora uigura, «è diventato quasi impossibile parlare di lavoro volontario in un gruppo di persone che rischiano di essere arrestate in ogni momento e per nessuna ragione».
-

900 edizioni
di BastaBugie
Da 18 anni al tuo servizio
Oltre le notizie per scoprire la verità
-
Pubblicato 10 anni fa...
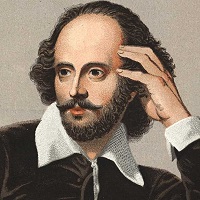
SHAKESPEARE
Era cattolico!
di Elisabetta Sala
Articolo del 21 novembre 2014
-
Libro della settimana

SACERDOZIO FEMMINILE?
Perché la Chiesa dice no
Ed. Fede & Cultura
Anno 2024 / pag. 144 / € 14
-
Video della settimana

DIECI COSE...
che gli europei pensano
a cura di Silver Nervuti
Durata: 3 minuti
-
Da FilmGarantiti.it

SISSI, LA GIOVANE IMPERATRICE
Il sogno di una monarchia cattolica
Giudizio: consigliato (*)
Genere: storico (1956)
-
I dossier di BastaBugie

COMUNIONE
Sulla lingua o in mano?
Dossier: 8 articoli e 1 video
-
Santo della settimana

SAN LEONARDO DA PORTO MAURIZIO
Apostolo della Via Crucis
di Ermes Dovico
Festa: 26 novembre
-
Video per la formazione

MILLENNIALS
Una generazione difficile
di Simon Sinek
Durata: 18 minuti
-
Personaggi del passato

EUGENIO SCALFARI
Giornalista
L'Espresso e Repubblica
1924 - 2022 (98 anni)










