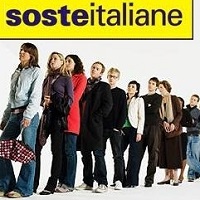I PIÙ LETTI DEL MESE
-
Il 1° libro di BastaBugie

CI HANNO PRESO PER IL COVID
Per non dimenticare tre anni di abusi di potere
Anno 2023 pag. 514 € 16
-

Audio registrati
-
La censura di YouTube

YouTube ha censurato in passato circa il 20% dei video che abbiamo pubblicato e oggi ci impedisce di pubblicare video con temi contrari al politicamente corretto (islam, gay, covid, ecc.)

SCEGLI UN ARGOMENTO
 Aborto
Aborto America
America Animalisti e vegetariani
Animalisti e vegetariani Attualità
Attualità Cinema
Cinema Comunismo
Comunismo Cristianesimo
Cristianesimo Ecologia
Ecologia Economia
Economia Eutanasia
Eutanasia Evoluzionismo
Evoluzionismo Famiglia e matrimonio
Famiglia e matrimonio Fecondazione artificiale
Fecondazione artificiale Immigrazione
Immigrazione Islam
Islam Libri
Libri Liturgia e sacramenti
Liturgia e sacramenti Morale
Morale Omelie
Omelie Omosessualità
Omosessualità Pedofilia
Pedofilia Pillole
Pillole Politica
Politica Santi e beati
Santi e beati Scienza
Scienza Scuola
Scuola Storia
Storia Televisione
Televisione
« Torna alla edizione
 LA GAZZARRA SU VENTOTENE E' LA PROVA DEL FALLIMENTO EUROPEO DI OGGI
LA GAZZARRA SU VENTOTENE E' LA PROVA DEL FALLIMENTO EUROPEO DI OGGI
Grande gazzarra in aula alla Camera ieri sul Manifesto di Ventotene al punto che il Presidente Fontana ha sospeso la seduta. La premier Giorgia Meloni è stata chiara e dura su quel documento, dissociandosene dicendo «nella manifestazione di sabato a piazza del Popolo e anche in quest'aula è stato richiamato da moltissimi partecipanti il Manifesto di Ventotene: spero non l'abbiano mai letto, perché l'alternativa sarebbe spaventosa». Durante le manifestazioni romane per l'Europa di sabato scorso era riemerso il Manifesto di Ventotene come guida ideale per i partecipanti. Dal palco di piazza del Popolo, Corrado Augias aveva detto: «Oggi questa piazza è di nuovo Ventotene».
Ventotene è stato il bollino di qualità posto sulla manifestazione, evidentemente accettato anche dalle associazioni cattoliche presenti. Però se si va a rileggere il Manifesto "Per un'Europa libera e unita" che Spinelli, Rossi e Colorni hanno scritto esuli nell'isola di Ventotene nel 1941 si capisce che ben poco è accettabile di quanto propone. In quelle righe, tra l'altro, si leggono puntualmente le premesse per il fallimento europeo di oggi.
Un primo elemento del Manifesto è di avere carattere rivoluzionario nel preciso senso socialista del termine: «La rivoluzione europea, per rispondere alle nostre esigenze, dovrà essere socialista». La democrazia per cui ci si deve battere è vista come uno strumento di questo obiettivo rivoluzionario e non come il fine dello stesso. Il Manifesto supera il concetto comunista di rivoluzione, sia perché condanna la violenza fisica, sia perché ritiene che in quel modo la classe operaia rimarrebbe chiusa in se stessa e non si collegherebbe con le rivendicazioni degli altri ceti, sia perché sarebbe un modo per allarmare preventivamente i conservatori e permettere loro di organizzarsi per evitarla.
IL SOCIALISMO DI VENTOTENE
Il Manifesto non usa parole dolci verso il comunismo: i comunisti «nelle crisi rivoluzionarie, [sono] più efficienti dei democratici; ma tenendo essi distinte quanto più possono le classi operaie dalle altre forze rivoluzionarie costituiscono nei momenti decisivi un elemento settario che indebolisce il tutto». Nonostante ciò, però, il socialismo di Ventotene concorda con gli obiettivi rivoluzionari di fondo del comunismo. Basti considerare cosa dice dell'abolizione della proprietà privata: «La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa, caso per caso, non dogmaticamente in linea di principio». La negazione del diritto naturale alla proprietà privata rimane, ma deve essere perseguita in modo dolce. Il progetto si colloca sulla linea che verrà battuta anche dal comunismo postbellico italiano di un socialismo che accetta la democrazia come strumento della rivoluzione, non come alternativa alla rivoluzione.
Il carattere rivoluzionario di Ventotene è diretto ad eliminare le nazioni dalla scena politica. La cosa viene fatta pregiudizialmente mediante l'equazione: nazione, nazionalismo, totalitarismo. La sua analisi dei totalitarismi di allora risente dell'animosità del momento e per questo è poco lucida, risente però anche della posizione ideologica assunta, con l'errore conseguente di considerare i totalitarismi come eccezione alla civiltà moderna anziché, come è stato dimostrato, come sua accelerazione.
Il Manifesto mette in guardia dalla restaurazione, dopo la guerra, dello Stato nazionale che, secondo le previsioni dei due autori, avverrà mediante la strumentalizzazione del sentimento patriottico. Lo scopo, invece, deve essere «la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in Stati nazionali sovrani». La lettera e lo spirito del Manifesto inducono a pensare che questo superamento della nazione non debba essere limitato ad una situazione e ad un tempo, ma che abbia una dimensione europea avendone una globale - «in cui diventi possibile l'unità politica dell'intero globo» - e che miri anche al superamento del concetto di patria. Il suo progetto di un'Europa federale ha questi inquietanti connotati.
LA DEMOCRAZIA È UN INGOMBRO
Rossi, Spinelli e Colorni vogliono quindi la rivoluzione socialista. Accettano in via di principio la democrazia, ma la considerano anche un ingombro nei momenti di tensione politica. Un concetto, questo, espresso in modo molto chiaro: «Nelle epoche rivoluzionarie, in cui le istituzioni non debbono già essere amministrate, ma create, la prassi democratica fallisce clamorosamente. La pietosa impotenza dei democratici nelle rivoluzioni russa, tedesca, spagnola, sono tre dei più recenti esempi». Quando il popolo fosse immaturo e diviso al proprio interno, guidato da «tumultuose passioni» più che dalla freddezza politica, «la metodologia democratica sarà un peso morto nella crisi rivoluzionaria». Da qui al passaggio alle guide politiche illuminate è breve. Il popolo dovrà essere fatto oggetto di opera di convinzione dall'alto da «capi che guidino sapendo dove arrivare». Quest'opera di convinzione e guida deve passare anche dalla lotta alle pretese della Chiesa cattolica. Il Manifesto propone l'abolizione del concordato, l'affermazione della pura laicità dello Stato e la supremazia dello Stato sulla società civile. In altri termini: un nuovo dirigismo ideologico.
Dalla lettura del Manifesto emergono molte preoccupazioni più che fiduciose sicurezze. Di più: molti dei danni prodotti dall'Unione Europea derivano proprio da quelle impostazioni debitamente aggiornate. I "capi" guidano dall'alto senza essere eletti, gli intellettuali organici all'europeismo di Ventotene indottrinano le masse, il laicismo delle élites di Bruxelles è diventato aria da respirare per la gente comune, la "sovranità assoluta degli Stati nazionali" ha assunto dimensioni europee, un "ceto assolutamente parassitario", che il Manifesto voleva eliminare col federalismo europeo, ha allignato proprio lì.
Anche il "burocratismo" e, oggi, il "militarismo" che a Ventotene venivano presentati come la peste, riemergono in sede europea "... per costruire un largo Stato federale, il quale disponga di una forza armata propria al posto degli eserciti nazionali".
Nota di BastaBugie: Eugenio Capozzi nell'articolo seguente dal titolo "Il feticcio di Ventotene e l'europeismo verticistico delle sinistre" spiega perché la Meloni, citando Ventotene, ha mostrato impietosamente i limiti di quello che è diventato un "feticcio", un mito politico, dopo il crollo del modello comunista: l'europeismo.
Ecco l'articolo completo pubblicato su La Nuova Bussola Quotidiana il 24 marzo 2025:
Leggendo nell'aula di Montecitorio alcuni passi palesemente illiberali del Manifesto di Ventotene redatto nel 1941 da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, e dichiarando che «questa non è la nostra Europa», Giorgia Meloni ha toccato veramente uno dei nervi più scoperti e sensibili della sinistra italiana. Perché ha mostrato impietosamente i limiti di quello che negli ultimi decenni è diventato un "feticcio", un mito politico, dopo il crollo del modello comunista: l'europeismo, declinato non tanto come modello di assetto politico-istituzionale, ma come dogma religioso, visione escatologica secolarizzata di una possibile redenzione collettiva. Come sono stati declinati il multiculturalismo, l "dirittismo", l'ambientalismo "gretista".
Hanno formalmente ragione quanti sostengono, criticando i modi dell'intervento della presidente del Consiglio, che un documento storico come il Manifesto dovrebbe essere adeguatamente contestualizzato per comprenderne il significato e il valore. Ma, appunto, una valutazione storica implica un esame critico, un'analisi che porti a distinguere "ciò che è vivo e cià che è morto" in esso, per dirla con la formula di Benedetto Croce. E questo è esattamente il contrario della mitizzazione che la cultura politica progressista da tempo fa del Manifesto, elevato in blocco a "testo sacro" supremo dell'ideale europeista. Ed è assolutamente incompatibile con l'indignazione, le lacrime, le accuse di "blasfemia", addirittura le richieste di mea culpa rivolte a chi si permette di evidenziare come molte delle idee espresse in quel testo siano in contraddizione con un modello di democrazia liberale fondato sulla limitazione rigorosa del potere, sul pluralismo e sulla sovranità popolare.
Se si vuole comprendere adeguatamente il Manifesto di Ventotene nel suo contesto storico, allora, va sottolineato innanzitutto che il pronunciamento di Spinelli, Rossi e Colorni non fu né il primo né l'unico programma per la costruzione dell'unità o del federalismo europeo nella sua epoca. Esso si inseriva, viceversa, all'interno di un vasto movimento politico-culturale in quella direzione, iniziato alla fine della prima guerra mondiale e proseguito fino alla fine della seconda. Che, a partire dal trauma profondo causato da quei conflitti e dall'ascesa dei regimi dittatoriali, indicava nel superamento strutturale della contrapposizione tra le nazioni europee la via per arrivare alla pace, e per salvare i princìpi di fondo della civiltà del continente.
Se proprio si vuole cercare un "padre fondatore" in questo senso lo si può trovare proprio in Italia, in Luigi Einaudi, che tra il 1918 e il 1919 nelle sue "Lettere di Junius" sul Corriere della Sera contestava l'internazionalismo della Società delle Nazioni per invocare un ordinamento federalista che archiviasse definitivamente, a tutti i livelli dell'organizzazione politica, lo Stato modernocome unica autorità legittima riconosciuta e l'idea della sovranità assoluta. Tra le due guerre l'ideale federalista e/o europeista veniva poi ripreso in varie declinazioni dal movimento Paneuropa fondato nel 1922 dal conte austriaco Richard Coudenhove-Kalergi, dal Progetto di Unione federale europea proposto nel 1930 alla Società delle Nazioni dal ministro degli esteri francese Aristide Briand, dal progetto di unione federale delle democrazie avanzato nel 1938 nel libro di Clarence Streit Union now, dall'associazione Federal Union fondata nel 1938 nel Regno Unito da intellettuali liberali e socialisti, e da molti altri.
Come si caratterizza il Manifesto di Ventotene all'interno di questo ampio dibattito? I suoi estensori - e in particolare Ernesto Rossi, che ne era allievo e corrispondente - dichiaravano di aver tratto ispirazione innanzitutto proprio dalle proposte federaliste di Luigi Einaudi. Ma Rossi aveva un'idea del liberalismo diversa, su molti punti, da quella dell'economista piemontese: un'idea radicale incentrata soprattutto sull'idea di combattere i monopoli economici attraverso un energico intervento regolatore dello Stato. Non sorprende, dunque, che la convergenza federalista tra Rossi, il socialista Colorni e un dissidente comunista come Spinelli producesse, nella tensione "messianica" della guerra e del confino a cui erano costretti dal regime fascista, un testo programmatico dai forti tratti "giacobini", ispirato dall'idea di derivazione leninista di una rivoluzione epocale che doveva essere portata a termine da un'avanguardia organizzata di dottrinari pronti all'azione, contro la confusione e le esitazioni regnanti nelle opinioni pubbliche. Né che in esso si sottolineasse soprattutto l'obiettivo di costruire un forte governo centralizzato sovranazionale, minimizzando le esigenze di limitazione del potere e della difesa di libertà, autonomie, pluralismo.
Per queste sue caratteristiche il Manifesto, pur facendo propria l'idea federale dal punto di vista di un ordinamento sovranazionale, si discostava sostanzialmente dall'ispirazione del federalismo einaudiano. E ugualmente si discostava dall'europeismo predicato in quegli anni nell'area dell'antifascismo cattolico: che avrebbe prodotto nel 1945 il suo testo più rilevante con Parte guelfa in Europa di Piero Malvestiti, fondatore del Movimento guelfo d'azione e poi della Democrazia cristiana insieme ad Alcide De Gasperi. Un europeismo, quest'ultimo, fondato innanzitutto sull'umanesimo cristiano, e poi sulla tradizione di autogoverno dei comuni italiani.
L'appello ideale del Manifeasto di Ventotene e la fondazione da parte di Spinelli del Movimento federalista europeo furono senza dubbio, nell'immediato dopoguerra, tra le influenze del dibattito che portò a costruire le prime istituzioni comunitarie. Ma non l'unica, e nemmeno la principale. Il piano Schuman del 1950, la CECA, la CED, la CEE nacquero soprattutto dalla cultura politica cattolico-liberale e cattolico-democratica, dall'atlantismo e dall'ispirazione funzionalista di Jean Monnet.
Non è un caso, però, che proprio il Manifesto sia stato adottato come "testo sacro" dalla sinistra italiana quando è maturata la sua "conversione" europeista, e che Spinelli sia stato "venerato" come suo principale "profeta". Tra le possibili accezioni del federalismo, infatti, quella di Ventotene appariva a reduci vari del marxismo - socialisti, comunisti, post-comunisti - come la più consona alle loro radici politiche per la sua impostazione centralistica, dirigistica e fortemente pedagogica.
E non è un caso che questa "affinità elettiva" si sia radicata ulteriormente, man mano che la costruzione degli ordinamenti comunitari, da Maastricht in avanti, slittava dall'originario approccio intergovernativo a una crescente torsione in senso oligarchico, tecnocratico, dirigistico, ideologico. Un approccio che, nel processo, metteva bruscamente da parte sia le aspirazioni all'attuazione di una autentica democrazia a livello continentale, fondata sulla responsabilità delle classi dirigenti rispetto al voto popolare, sia le radici culturali e religiose cristiane, "carolingie", che avevano ispirato i veri padri fondatori dell'integrazione continentale: De Gasperi, Schuman e Adenauer. E che, all'inverso, veniva avvertita come naturalmente congeniale da una cultura politica - quella del progressismo post-guerra fredda - confluita nell'esaltazione delle super-élites transnazionali globaliste e, spesso, nel fastidio esplicito verso la libertà di espressione e il pluralismo.
-
BastaBugie consiglia

LA SAPIENZA CRISTIANA
Cuore della scuola cattolica
Osservatorio Van Thuan
Lonigo (VI), 05/04/2025
-
Pubblicato 10 anni fa...
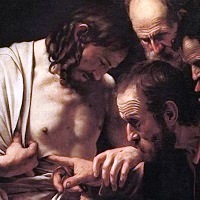
SETTIMANA SANTA
Non è una parentesi
di Don Stefano Bimbi
Articolo del 1° aprile 2015
-
Libro della settimana
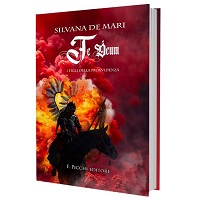
TE DEUM
I figli della Provvidenza
di Silvana De Mari
Anno 2025 / pag. 200 / € 19
-
Video della settimana

O TUTTO, O NIENTE!
Suor Clare Crockett
di Don Roberto Fiscer
Durata: 3 minuti (2021)
-
Da FilmGarantiti.it

FATIMA
Documentario, cartone animato e film
Giudizio: ottimo (**)
Genere: storico (2020)
-
I dossier di BastaBugie

MATTARELLA
Il presidente cattocomunista
Dossier: 13 articoli + 1 video
-
Santo della settimana

SAN GIOVANNI NEPOMUCENO
Il martire del segreto confessionale
di Gianpiero Pettiti
Festa: 20 marzo
-
Video per la formazione
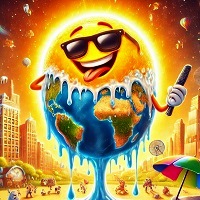
RISCALDAMENTO GLOBALE?
Tutte previsioni sbagliate
di Nicola Scafetta
Durata: 52' (08/06/2024)
-
Personaggi del passato

GIUSEPPE GARRONE
Attivista prolife
Cofondatore del Progetto Gemma
1939 - 2011 (72 anni)